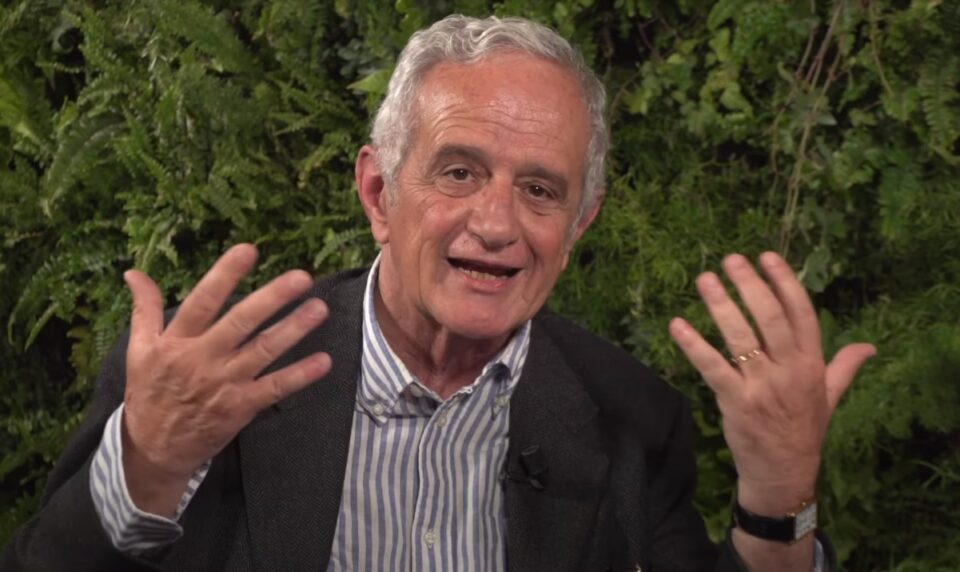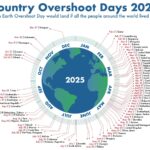Intervista a Roberto Cetera, inviato de L’Osservatore Romano in Terra Santa.
Nel pieno del conflitto di Gaza, Roberto Cetera, inviato in Terra Santa de L’Osservatore Romano, ha partecipato alle giornate di Impatta Disrupt, il Festival dell’Innovability. Di passaggio a Roma e in procinto di tornare a Gerusalemme, Cetera ci ha concesso questa intervista, successivamente trasmessa il 22 aprile da Rai News, nella maratona One People One Planet della Giornata Mondiale della Terra. Abbiamo colto l’occasione di dialogare con un testimone autorevole e diretto di questo lungo conflitto, per approfondire alcuni aspetti che di solito vengono tralasciati o messi in secondo piano, nei consueti dibattiti pubblici relativi alla crisi israelo-palestinese. Ovvero le implicazioni ambientali della guerra: dalle dispute sulle risorse naturali, da ascrivere tra le cause dei combattimenti, alle conseguenze deleterie per il territorio dell’utilizzo di armi pesanti.
Roberto, come vive la Terra Santa questo momento? Che importanza riveste questa parte di mondo nelle dinamiche geopolitiche, in una fase così complessa?
È certamente una situazione che ormai permane grave da più di diciotto mesi. Molto grave, come sappiamo tutti, a Gaza; ma grave anche in Palestina e in Israele. Entrambe le popolazioni non reggono più la guerra… anche in Israele. L’8 e il 9 maggio a Gerusalemme ci sarà infatti una grandissima manifestazione – qualcuno dice: forse la più grande manifestazione della storia di Israele – dei movimenti pacifisti, israeliani e palestinesi, che chiedono la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.
Quest’anno sono 77 anni che dura il conflitto tra Israele e paesi arabi, prima, e adesso con i palestinesi. Ma questa di Gaza, iniziata l’8 ottobre del 2023, è sicuramente la guerra più lunga e anche più cruenta. Ormai abbiamo superato ampiamente i 50.000 morti, molti dei quali civili. Non c’è famiglia a Gaza che non abbia avuto un parente ucciso o ferito. E i numeri sono bassi, perché probabilmente ci sono ancora molti corpi sotto le macerie.
Gaza è totalmente distrutta. Il 90% delle case non sta più in piedi. Ci sono probabilmente un milione di persone che vivono nelle tende piantate lungo il litorale. Manca l’acqua, l’elettricità; da un più di un mese ormai non arrivano più aiuti umanitari all’interno della striscia di Gaza: non per cattiva volontà, ma perché Israele lo impedisce, utilizzando in una maniera assurda, inconcepibile, anche l’arma dell’aiuto umanitario. Non si sa come andrà a finire; perché ormai da un anno e mezzo, attività politica e diplomatica hanno lasciato il passo alla sola attività militare. Si parla soltanto di razzi, bombe, morti e feriti. Questo è molto duro.
Un’altra cosa di cui non si parla sono gli effetti sull’ambiente. Sembra secondario, ma in realtà a lungo termine questa situazione che si prolunga da decenni avrà molto peso sull’ambiente. E poi ci sono le cause ambientali di questo conflitto.
La relazione tra ambiente e guerra è duplice. L’ambiente è al tempo stesso origine e conseguenza della guerra. Pensiamo per esempio al tema dell’acqua. La sorgente principale per tutta la Palestina è il Giordano, e c’è un continuo prelievo da parte dei kibbutz israeliani lungo la valle. E c’è il costante furto d’acqua da parte dei coloni, i settlers ebraici, che hanno occupato i territori palestinesi. Di recente ho intervistato alcuni pastori della Cisgiordania che vedono il proprio bestiame morire per mancanza d’acqua. Quello è un posto dove l’acqua conta più del petrolio per la forte calura. Anche l’acqua che riescono a tenere dentro i container, viene spesso sabotata o rubata dai coloni.
La stessa cosa avviene per elettricità. Ho un ricordo terribile dei primi giorni dopo il 7 ottobre: le immagini in televisione del ministro israeliano dell’energia che chiudeva la l’erogazione dell’elettricità a Gaza. La sofferenza che stanno vivendo in questo momento gli abitanti di Gaza è assolutamente indicibile.
Tornando al tema dell’ambiente – in questa che in fondo è piccola area geografica – l’utilizzo e lo sfruttamento delle fonti energetiche e dell’acqua è molto importante; ma c’è anche la conseguenza: uno dei temi che qualcuno comincia a trattare è la ricostruzione di Gaza. C’è un problema di rifiuti inerti; e col 90% delle case distrutte sarà una cosa che richiederà anni di lavoro, e soprattutto siti di smaltimento. Grosso modo gli abitanti di Gaza sono 2,5 milioni, come a Roma. Immaginate Roma distrutta: dove portare [tutti questi detriti]? Poi ci sono, ahimè, gli effetti negativi di tutte quelle armi che rilasciano metalli pesanti.
La soluzione che viene sempre auspicata per questo conflitto è la separazione fra i due popoli e le due terre. Ma tu hai fatto cenno a qualcosa che forse ci fa capire che, alla base, i sentimenti sono gli stessi. C’è nella società civile israeliana e palestinese una volontà di mettere fine a tutto questo, anche unendosi?
Sicuramente la guerra ha prodotto una forte stanchezza. Il governo di Netanyahu è oggi di fatto un governo di minoranza all’interno del paese. Poi, i sentimenti che pervadono la popolazione israeliana sono diversi. C’è chi dice “finiamo la guerra perché dobbiamo riprenderci gli ostaggi”; Però oggi la maggioranza degli israeliani è contro l’ipotesi dei due stati: circa il 70% di essi non crede a questa ipotesi. Dall’altra parte, ugualmente, c’è una grande difficoltà in campo palestinese; data dal fatto che i tentativi di negoziazione e accordo – perseguiti dall’autorità dallo stato palestinese di Ramallah e di Abu Mazen – finora non hanno dato nessun risultato. Questo spiega anche un po’ il fenomeno di Hamas: che non è solo militare e terroristico, ma anche politico e sociale.
Io credo che ci sia una necessità propedeutica a qualsiasi ipotesi di soluzione del problema: un radicale ricambio di leadership in ambedue i campi. Devono emergere nuove leadership. Tanto nella società israeliana che in quella palestinese ci sono energie vive che vogliono trovare non solo una soluzione politica. Si era andati vicini a una soluzione politica trent’anni fa con gli accordi di Oslo, ma era rimasta ristretta alle élite politiche, e per questo è fallita e non è andata avanti. Occorre trovare invece delle soluzioni che passino attraverso le due società; che i due popoli imparino a rispettarsi, a riconoscere il diritto alla dignità, alla sicurezza e alla libertà di di entrambi. Non è solo uno slogan politico: entrambi i popoli immaginano la propria terra, come si dice: “dal fiume al mare”. Ciò che sogno, spero, immagino, è che questo non sia un motivo di conflitto, ma che entrambi possano vivere liberamente insieme, in condivisione dalla terra al mare; che non sia difficile per un ebreo per andare a Betlemme, a Nablus o a Gerico, così come non sia difficile per un palestinese sentirsi ancora oggi a casa propria a Jaffa o a Nazareth.